Quando, quasi un secolo fa, entrò ufficialmente in funzione per dissetare Firenze, l’acquedotto di Mantignano era considerato un impianto all’avanguardia. Costò quasi il doppio dello stadio comunale di Campo di Marte, inaugurato qualche anno dopo, e una volta e mezza quanto speso per costruire Ponte alla Vittoria. I lavori a Santa Maria a Mantignano – nella zona sudovest della città – furono completati negli anni ’30 del Novecento, grazie all’impiego di oltre cento maestranze, dando vita alla seconda moderna infrastruttura di approvvigionamento idrico di Firenze dopo l’Anconella.
Un’opera mastodontica per l’epoca. Le due potenti pompe impiegate furono addirittura brevettate e testate accuratamente a Milano, in una sala dove l’azienda produttrice simulò gli ambienti dell’impianto fiorentino. A quasi cento anni di distanza, nel complesso di Mantignano si intrecciano architettura, soluzioni ingegneristiche e vicende storiche legate alla liberazione dal nazifascismo.
L’impianto di Mantignano: i “segni particolari”
L’acquedotto di Mantignano, sottoposto nel corso dei decenni a interventi di ammodernamento, è tuttora in funzione e conserva importanti esempi architettonici di razionalismo, come l’imponente officina centrale. A ricostruire il passato di questo pezzo di città sono stati di recente tre appassionati di storia, impegnati nella valorizzazione della Memoria e della Resistenza dell’Oltregreve fiorentino: Matteo Mengoni, Roberto Fiordiponti e Maurizio Dell’Agnello.
Le vicende dell’impianto sono infatti legate a doppio filo al sacrificio di cinque partigiani che il 4 agosto 1944 lo salvarono dalle mine tedesche, evitando che Firenze rimanesse a secco d’acqua potabile. Gli ordigni collocati sulle grandi pompe di spinta avrebbero provocato danni gravi, riparabili solo con lunghi tempi d’intervento.
Dopo anni di ricerche, raccolte di testimonianze e documenti è nato un percorso fatto di quattro mostre e altrettanti cicli di incontri, promossi dal 2021 al 2024 in occasione degli anniversari del 4 agosto, patrocinati dal Comune di Firenze e realizzati in collaborazione con il Quartiere 4 e la Casa del Popolo di Ugnano. Ogni anno l’iniziativa si è concentrata su un luogo diverso: dal ponte che a Mantignano è soprannominato “dei cazzotti” (smantellato nel 2024), allo stesso acquedotto, fino alla distruzione della Chiesa di Santo Stefano.
Ma accanto agli eventi storici, sono tanti gli aspetti da approfondire, a partire dalle peculiarità dell’acquedotto di Mantignano a livello architettonico. “Se le altre grandi opere fiorentine del tempo furono progettate da nomi affermati, penso a Pier Luigi Nervi per lo stadio e a Giovanni Michelucci per la stazione di Santa Maria Novella, questo fabbricato con tutta probabilità fu frutto degli uffici tecnici del Comune – spiega Maurizio Dell’Agnello -. Nonostante non porti la firma di ‘archistar’ dell’epoca, la struttura testimonia un punto di svolta verso il razionalismo funzionale fiorentino”.
La storia dell’acquedotto di Santa Maria a Mantignano
Ma facciamo un passo indietro. L’idea di creare un nuovo acquedotto nella zona di Santa Maria a Mantignano nacque a seguito della crisi idrica dei primi anni del Novecento, quando a Firenze la richiesta di acqua per abitante era salita fino a 188 litri al giorno. Dopo i primi saggi, i cantieri presero il via nel 1928 nella zona lungo la riva sinistra dell’Arno, compresa fra la confluenza della Greve e la frazione di Ugnano. Tra le opere realizzate inizialmente figuravano pure un’officinetta elevatoria con due motori e un ponte di servizio in cemento armato sulla Greve (fatto saltare in aria dalle truppe tedesche nel 1944 e poi ricostruito), per consentire il passaggio di una condotta lunga 6 chilometri e mezzo diretta al Ponte alla Carraia per l’interconnessione con la rete cittadina.
Nell’agosto del 1929 l’acquedotto di Mantignano iniziò a fornire circa 10.000 metri cubi di acqua al giorno, mentre si progettava già un potenziamento dell’impianto. Un’infrastruttura strategica, che richiamò a Firenze esponenti di spicco del governo fascista, come il neoministro dell’Aeronautica Italo Balbo, che il 27 ottobre dello stesso anno arrivò nell’impianto per la cerimonia di inaugurazione.
L’officina dell’acquedotto di Mantignano, esempio unico di razionalismo
I lavori a Mantignano proseguirono negli anni Trenta con la costruzione dell’elemento architettonico di maggiore pregio, la grande officina centrale di sollevamento e spinta dell’acquedotto, il cuore di tutto il sistema. La pianta a croce greca dell’edificio ricorda i modelli classici. A saltare all’occhio è soprattutto la maestosa facciata, con all’ingresso quattro imponenti colonne che richiamano il pronao dei templi ellenici. In questo contesto ci sono però degli inserimenti più moderni, come le alte vetrate laterali e i grandi lucernari sul soffitto, oltre a “tesori” custoditi all’interno della palazzina. Un’elegante scala porta al piano superiore e agli ambienti destinati al personale, in cui i vari elementi, dai termosifoni ai lavandini dei bagni, sono stati abbelliti con ornamenti dal sapore Liberty.
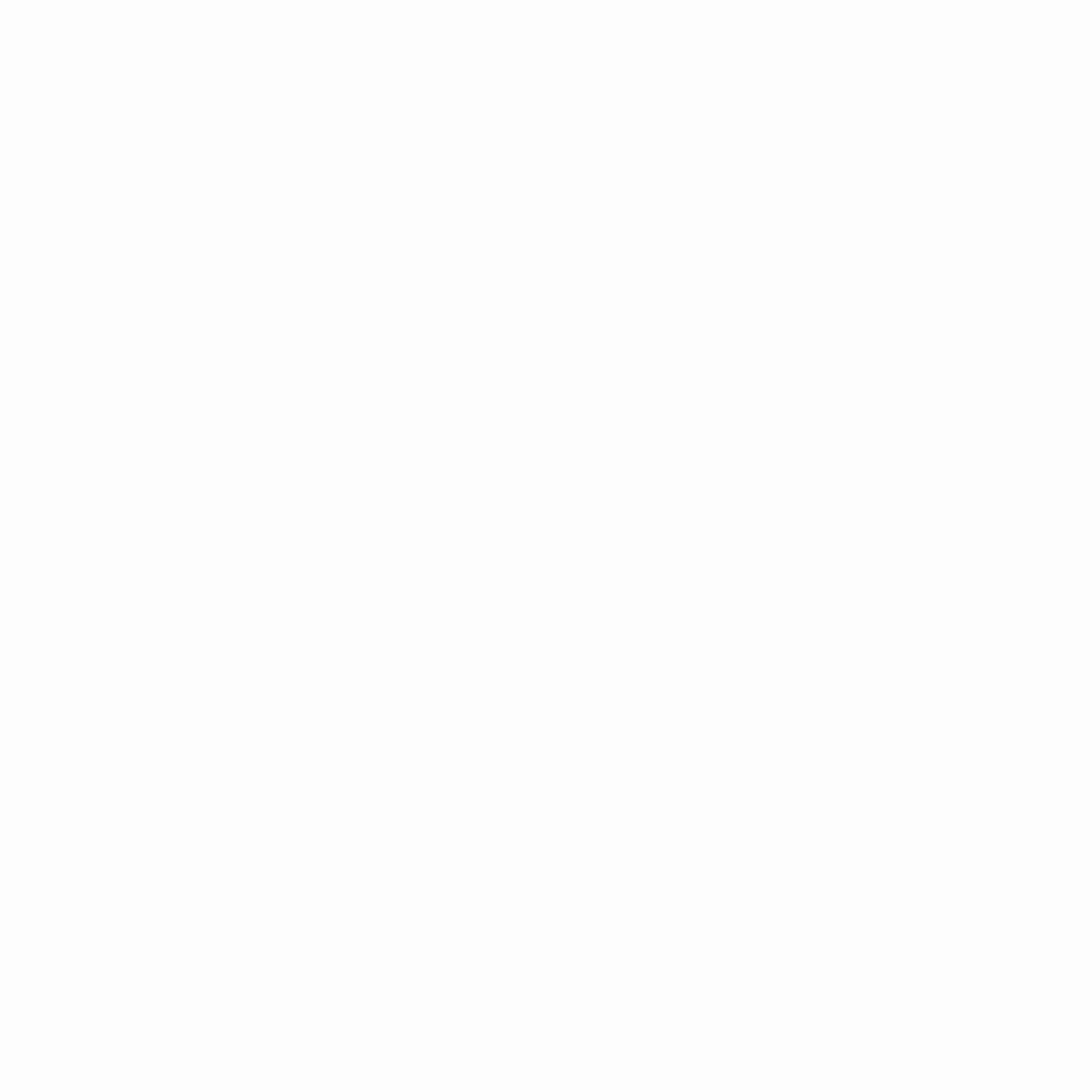
“Pur facendo riferimento ai canoni del tempio classico, la struttura di questa officina sembra quasi precorrere i tempi – osserva Dell’Agnello -. Non si tratta più di un’architettura che potremmo chiamare di propaganda, come il Palazzo dei Sindacati di Lastra a Signa progettato da Adolfo Coppedè, edificio quasi coevo, che con le sue decorazioni ispirate all’antica Roma fa riferimento ad aspetti ideologici come la ‘romana specie’. L’acquedotto invece è un luogo di lavoro. Qui non si ritrova un fine celebrativo del regime. Vengono introdotte scelte strutturali e funzionali che rivedremo poi in altre opere cittadine immediatamente successive, come i grandi finestroni del fabbricato passeggeri della stazione Santa Maria Novella di Giovanni Michelucci o le fattezze dell’ingresso monumentale dello stadio comunale”.
Le caratteristiche architettoniche dell’impianto sono illustrate anche nel volume Aquae Ductae, il libro fotografico dedicato alle infrastrutture di pregio gestite da Publiacqua. La pubblicazione raccoglie gli scatti di Davide Virdis, accompagnati dai commenti del professor Fabio Fabbrizzi, che a proposito della facciata della centrale di sollevamento di Mantignano scrive:
“I ritmi verticali delle scansioni finestrate, così come il disegno scarno e semplificato dei particolari, hanno la forza di conferire all’insieme una nota evidente di razionalità, la quale si sovrappone al rigore post-neoclassico del disegno generale, con il risultato di collocare quest’architettura in un milieu ibrido, tra Eclettismo e Modernismo. Centralità, simmetria, ritmi e scansioni angolari mettono in risalto la reciprocità tra il volume costruito e il disegno del verde circostante, evidenziando la loro simultanea ideazione”.
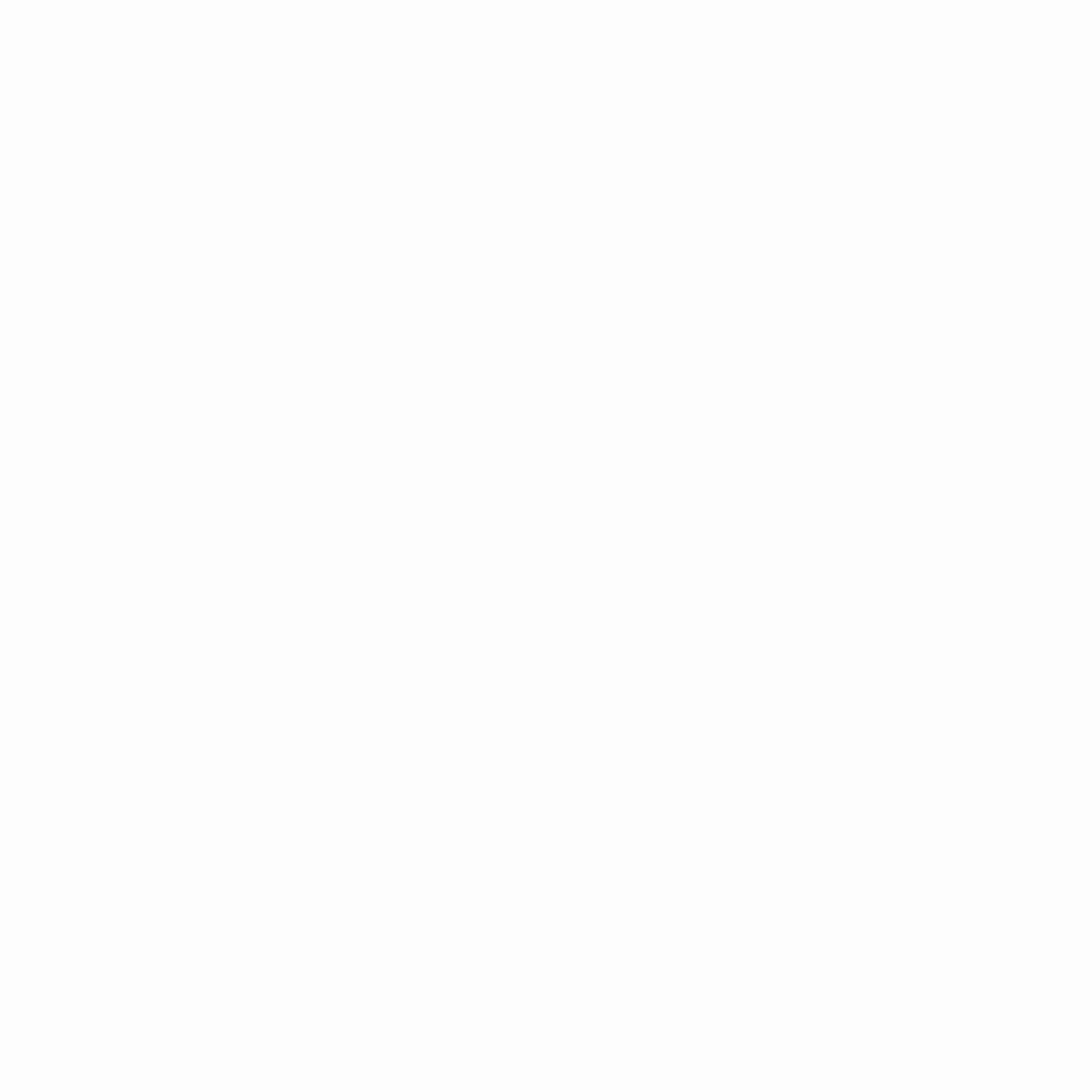
Una spesa record per l’epoca
La seconda parte di interventi all’acquedotto di Mantignano si concluse ufficialmente nel settembre 1936 con 20 pozzi realizzati e un’area complessiva di 28 ettari organizzata con viali, aiuole, strade di servizio e alberature, tuttora visibili. Si tratta di un grande parco, che in parte è stato restituito a Firenze tra il 2010 e il 2011 da Publiacqua. In tutto l’opera costò 12,7 milioni di lire, una cifra importante per l’epoca, basti pensare che Ponte alla Vittoria, inaugurato nel 1932, costò 7,7 milioni di lire, mentre per lo stadio di Firenze, intitolato nel 1931 a Giovanni Berta (poi diventato nel secondo Dopoguerra “stadio comunale” e infine “Artemio Franchi”), furono spesi 6,8 milioni. Oggi l’acquedotto di Mantignano può arrivare a immettere in rete 800 litri al secondo di acqua potabile, contribuendo all’approvvigionamento idrico di Firenze.
Potrebbero interessarti anche…
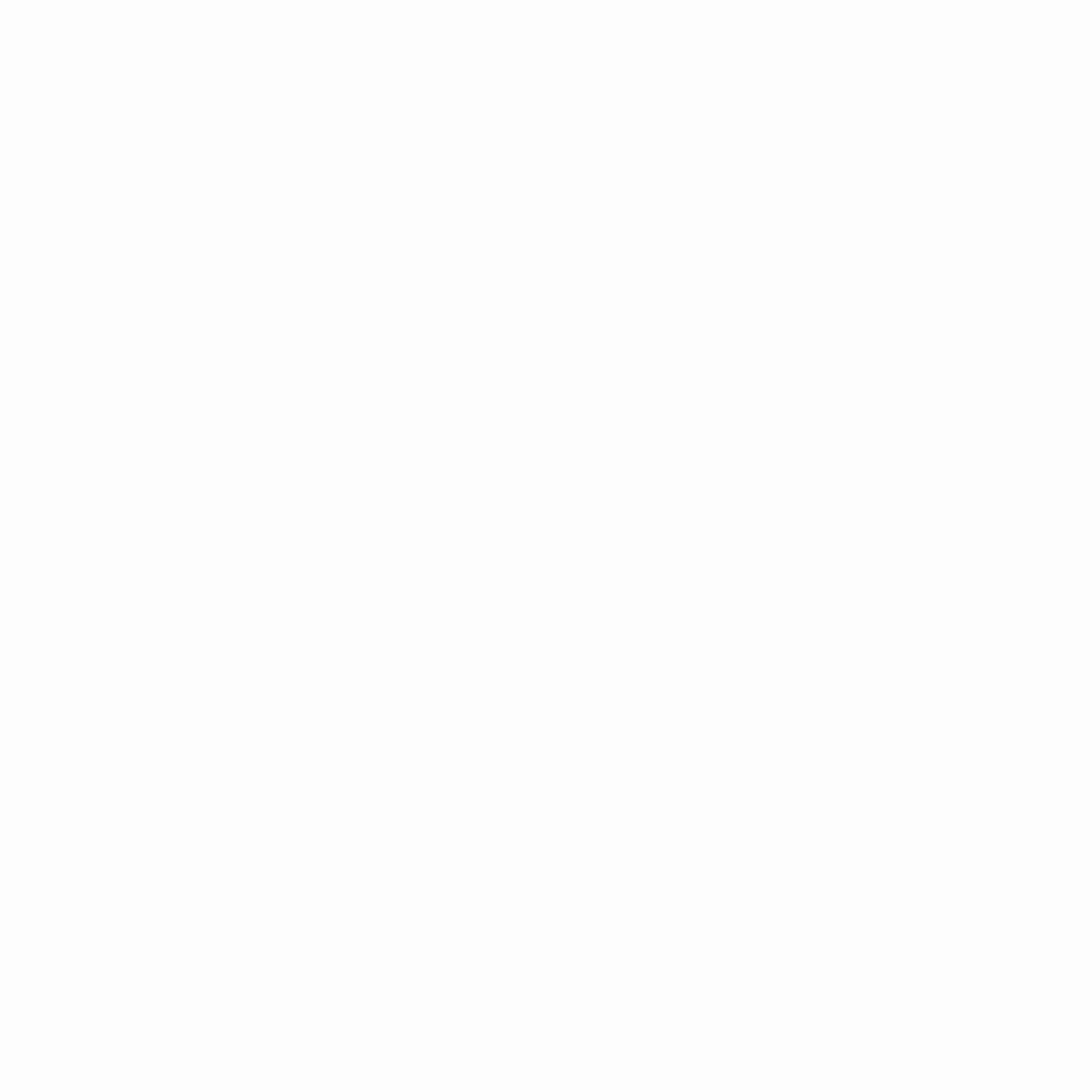
Publiacqua nella top 10 nazionale per la Qualità contrattuale
Tempi rapidi, accessibilità, chiarezza nella relazione con i cittadini: sono questi i principali parametri con cui in Italia si misura…
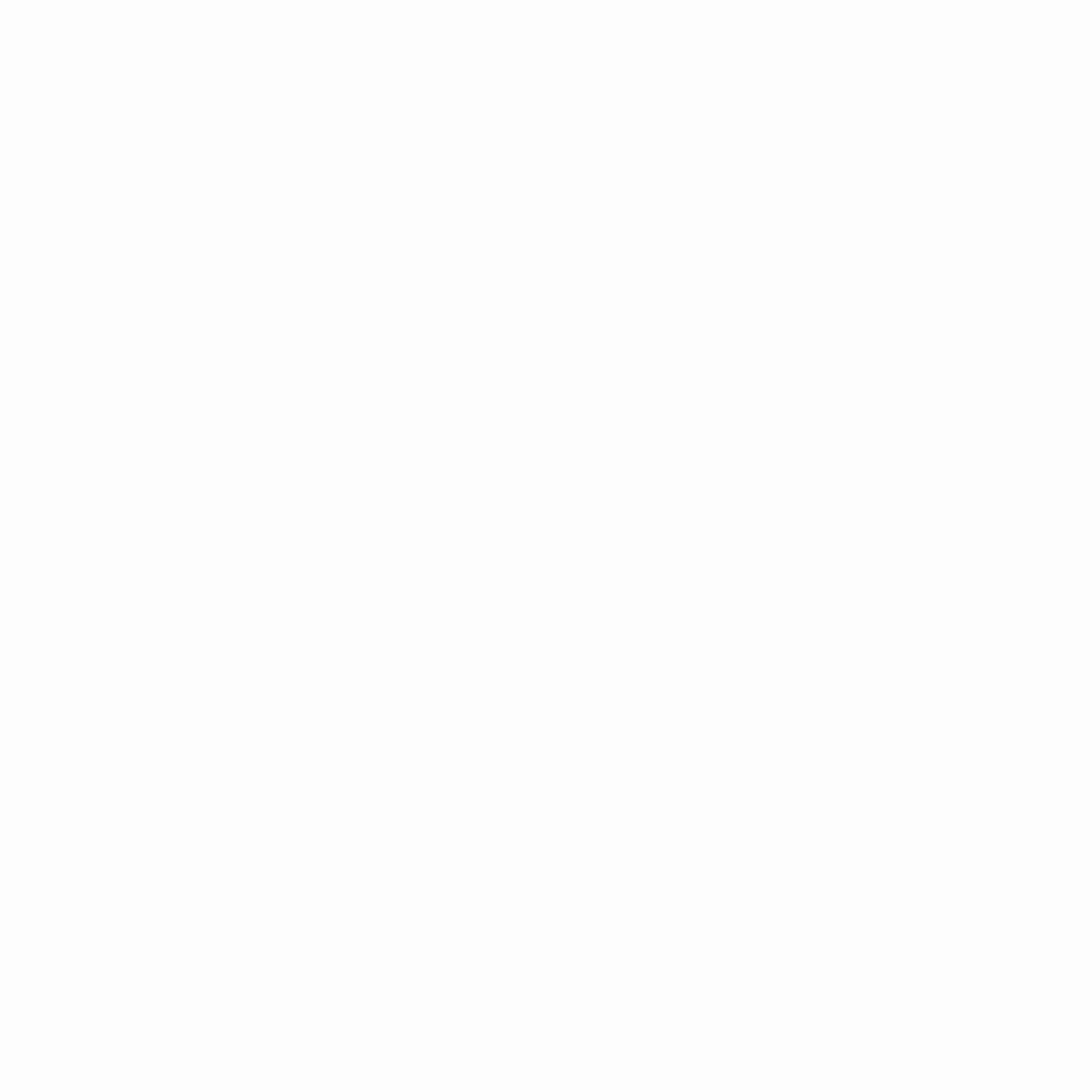
Chi determina la tariffa del servizio idrico integrato
Quando arriva la bolletta dell’acqua, può sorgere spontanea una domanda: chi determina veramente la tariffa del servizio idrico integrato? Non…
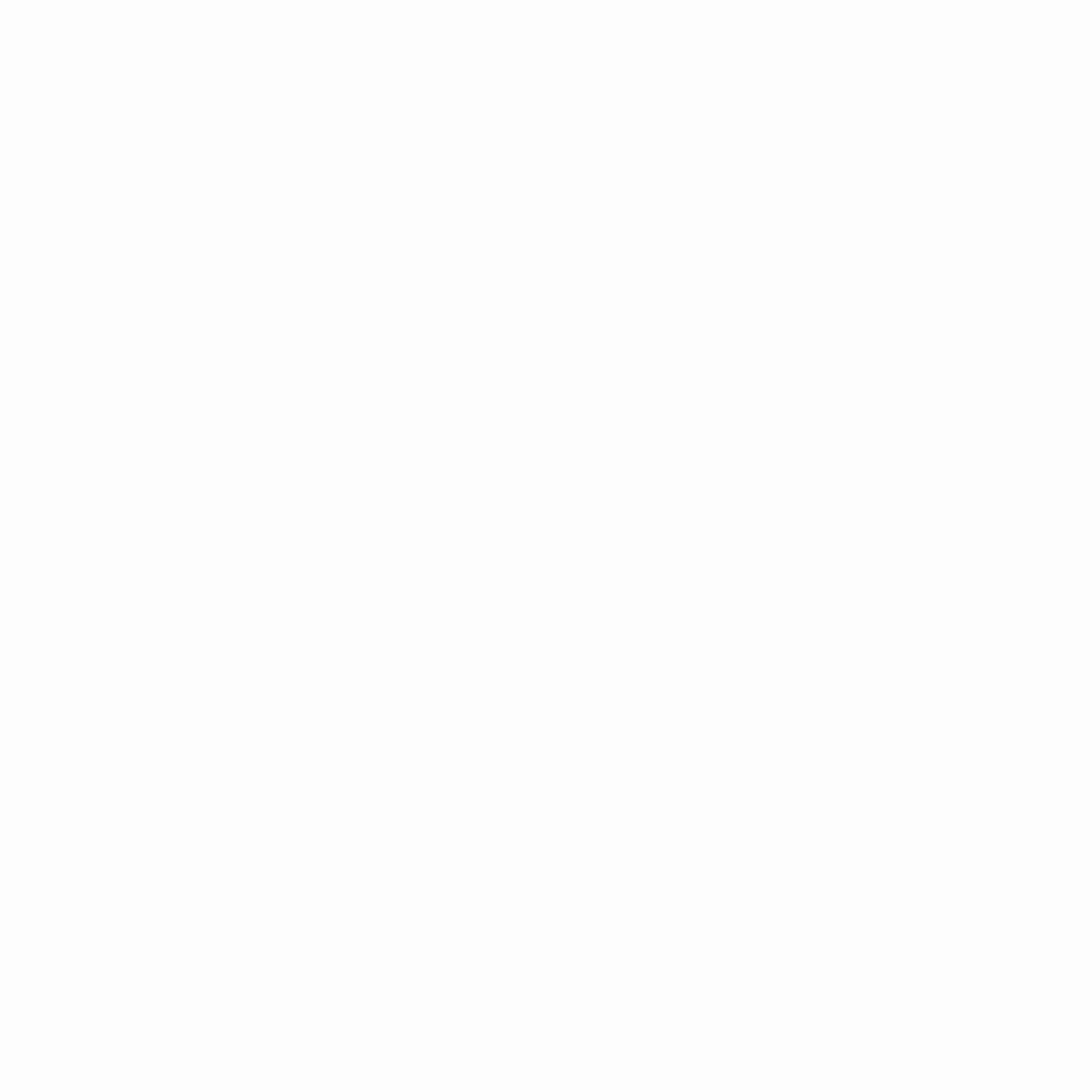
Perché la tariffa idrica non è uguale in tutta Italia
Paghiamo tutti l’acqua potabile, ma non allo stesso modo. A parità di consumi, famiglie che vivono in città diverse possono…

