Quattro coppie di potenti pompe, due turbine idrauliche per sfruttare il dislivello dell’Arno e due macchine a vapore che entravano in azione in situazioni di secca. Era questa la “forza” della Fabbrica dell’acqua di Firenze, la centrale di sollevamento che permetteva il funzionamento dell’intero acquedotto storico, immettendo la risorsa idrica nella rete di distribuzione. A fine Ottocento rappresentava il tassello fondamentale per dissetare la città, dopo secoli in cui l’approvvigionamento si era basato su una miriade di piccoli pozzi urbani, caratterizzati da una scarsa qualità dell’acqua.
Lo stabilimento, che si trovava a pochi passi da Torre San Niccolò e dall’omonima pescaia, è stato demolito durante gli anni Sessanta, ma il ricordo dell’impianto resta impresso nelle fotografie in bianco e nero, nelle cronache dell’epoca e nei progetti ufficiali firmati da Raffaele Canevari e Luigi Del Sarto. A testimoniare la sua presenza oggi rimangono le fondamenta e i bastioni circolari che affiorano dal fiume, ai piedi della terrazza che in tempi recenti è stata intitolata a Riccardo Marasco.

Com’era fatta la centrale di sollevamento
A seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale di Firenze del progetto dell’acquedotto Canevari-Del Sarto, i lavori per costruire la Fabbrica dell’acqua furono affidati ufficialmente nel 1871, per concludersi nel 1876, dopo ampliamenti e modifiche in corso d’opera. L’acquedotto nella sua interezza fu inaugurato invece il 3 giugno 1877. L’idea su cui si basava era piuttosto innovativa per l’epoca: l’acqua raccolta in una galleria filtrante, lunga circa 1.500 metri tra l’Anconella e la pescaia di San Niccolò, veniva indirizzata a questa centrale di sollevamento e raccolta in una cisterna di accumulo, sotto il piano stradale, per poi essere pompata verso serbatoi posti sulle prime colline cittadine. Da qui veniva distribuita nelle case e nelle botteghe dei fiorentini.
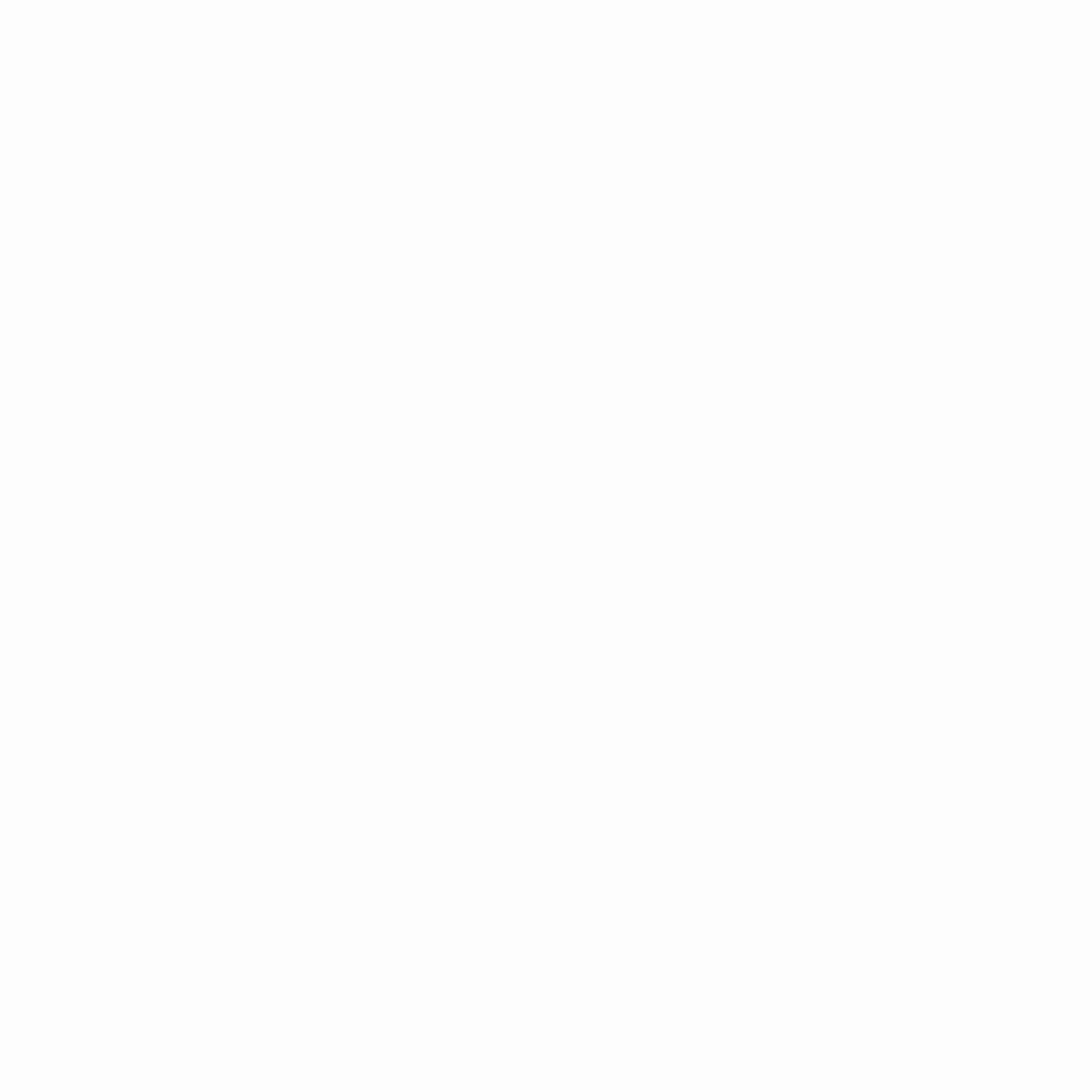
L’edificio della Fabbrica dell’acqua fu eretto in prossimità dell’alveo dell’Arno, davanti a Torre San Niccolò, in una posizione elevata rispetto al corso d’acqua, lì dove in precedenza sorgevano alcuni mulini. La collocazione, già indicata nel 1856 come luogo ideale per ospitare un’infrastruttura idrica anche dall’architetto di Firenze Capitale Giuseppe Poggi, fu scelta proprio per sfruttare il dislivello generato dalla biglia.
Il complesso era composto da tre grandi capannoni addossati, coperti da un tetto a volta in ferro e sovrastati da una ciminiera. Il primo ambiente ospitava le caldaie a vapore, il secondo e il terzo le pompe, le turbine e la sala macchine, mentre un quarto stabile più piccolo era adibito inizialmente a deposito di carbone. L’architettura industriale esteriore, che ricalcava lo stile delle attività produttive di fine Ottocento, non incontrò il favore di tutti. Tra le voci critiche pure quella di Giuseppe Poggi che criticò aspramente l’opera, perché – secondo il suo parere – risultava inopportuna per il decoro della città.
Il funzionamento della Fabbrica dell’acqua di Firenze
La centrale di sollevamento funzionava principalmente grazie all’acqua dell’Arno che, dopo essere stata filtrata da una rete di protezione per evitare l’ingresso di materiale galleggiante, entrava nella parte inferiore dello stabilimento tramite un canale regolato da una paratoia. Passava quindi in due pozzi, mettendo in movimento due turbine idrauliche Girard da cui veniva generata l’energia per alimentare quattro pompe a pistone orizzontale. Tre potevano sollevare fino a 80 litri al secondo, mentre la quarta – costruita dalla Fonderia del Pignone – 40 litri al secondo. Infine, l’acqua del fiume veniva convogliata nel canale che passa tuttora sotto i lungarni Serristori e Torrigiani, e restituita all’Arno. Lo sbocco finale del condotto è ancora visibile: se dalla sponda degli Uffizi si volge lo sguardo verso il lato di piazza di Santa Maria Soprarno si nota una grande volta, nel tratto compreso tra Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio.
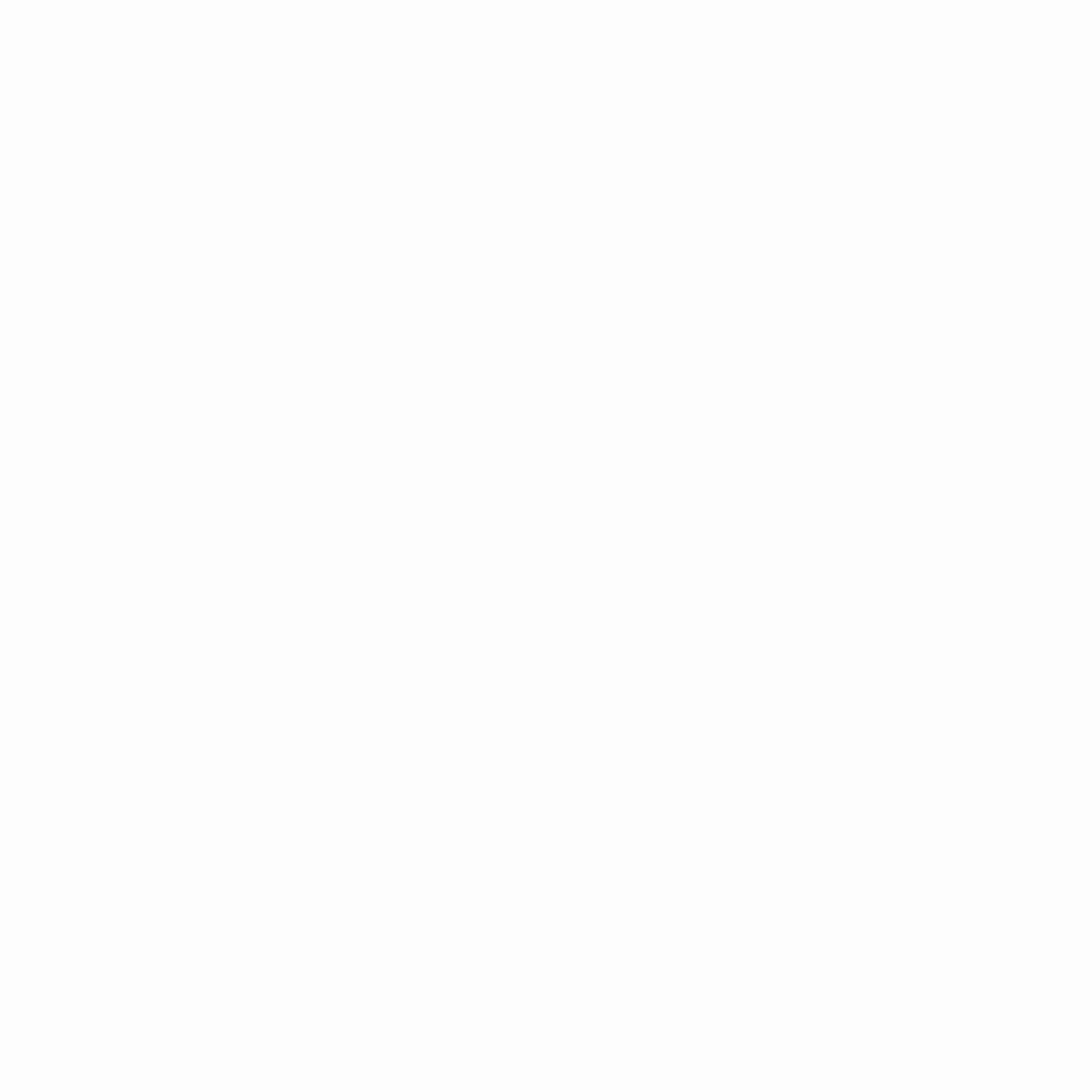
Durante l’estate e nei periodi di secca, per consentire alle pompe di continuare a lavorare nonostante il basso livello fluviale, entravano in azione le due macchine a vapore Corliss-Inglis, alimentate a carbone. Furono usate fino al 1916, quando la struttura venne dotata di elettropompe e la ciminiera fu rimossa.
Durante i lavori per l’acquedotto storico di Firenze fu realizzata anche una galleria binata lunga 250 metri, posta 5 metri sotto il letto dell’Arno, grossomodo all’altezza della pescaia di San Niccolò. Uno dei due tunnel gemelli serviva per consentire il passaggio da una sponda all’altra delle condutture che partivano dalla Fabbrica dell’acqua, l’altro invece fu creato per portare alla centrale di sollevamento l’eventuale risorsa captata sulla riva destra grazie a uno sviluppo del sistema acquedottistico di Firenze che però non è stato mai attuato. Questo “corridoio” sotterraneo è tutt’oggi presente e la Regione Toscana, insieme al Comune, sta valutando la sua messa in sicurezza per l’apertura all’accesso dei cittadini e dei turisti.
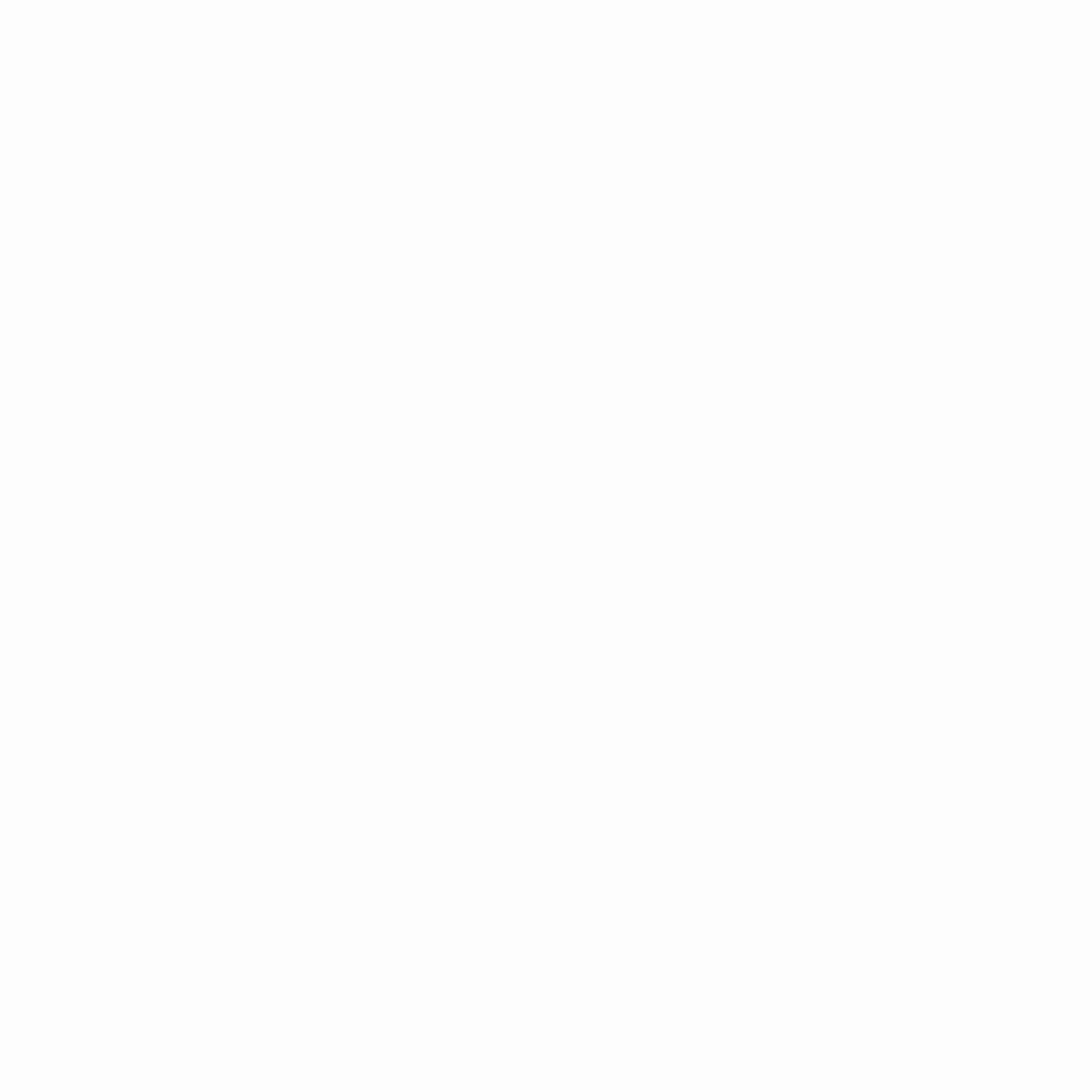
Gli ultimi anni della vecchia centrale
La Fabbrica dell’acqua è rimasta in servizio fino agli anni Cinquanta, perdendo gradualmente il suo ruolo nell’approvvigionamento idrico di Firenze a seguito del potenziamento dell’impianto dell’Anconella, avvenuto tra il 1957 e il 1961. Negli anni Ottanta è poi entrata in funzione l’attuale centrale di spinta dell’Anconella, capace di immettere in rete 1.000 litri al secondo. La demolizione dei vecchi capannoni di San Niccolò si concluse nell’agosto del 1963, lasciando spazio a giardini sopraelevati affacciati sul fiume.
I “sotterranei” della Terrazza Marasco però custodiscono ancora un pezzo del vecchio stabilimento di sollevamento. Alcuni di questi ambienti sono stati sfruttati durante i lavori per la creazione di una moderna centrale idroelettrica, parte del piano della Regione Toscana per recuperare 13 pescaie presenti lungo l’Arno e rendere il fiume una fonte di energia pulita.
Potrebbero interessarti anche…
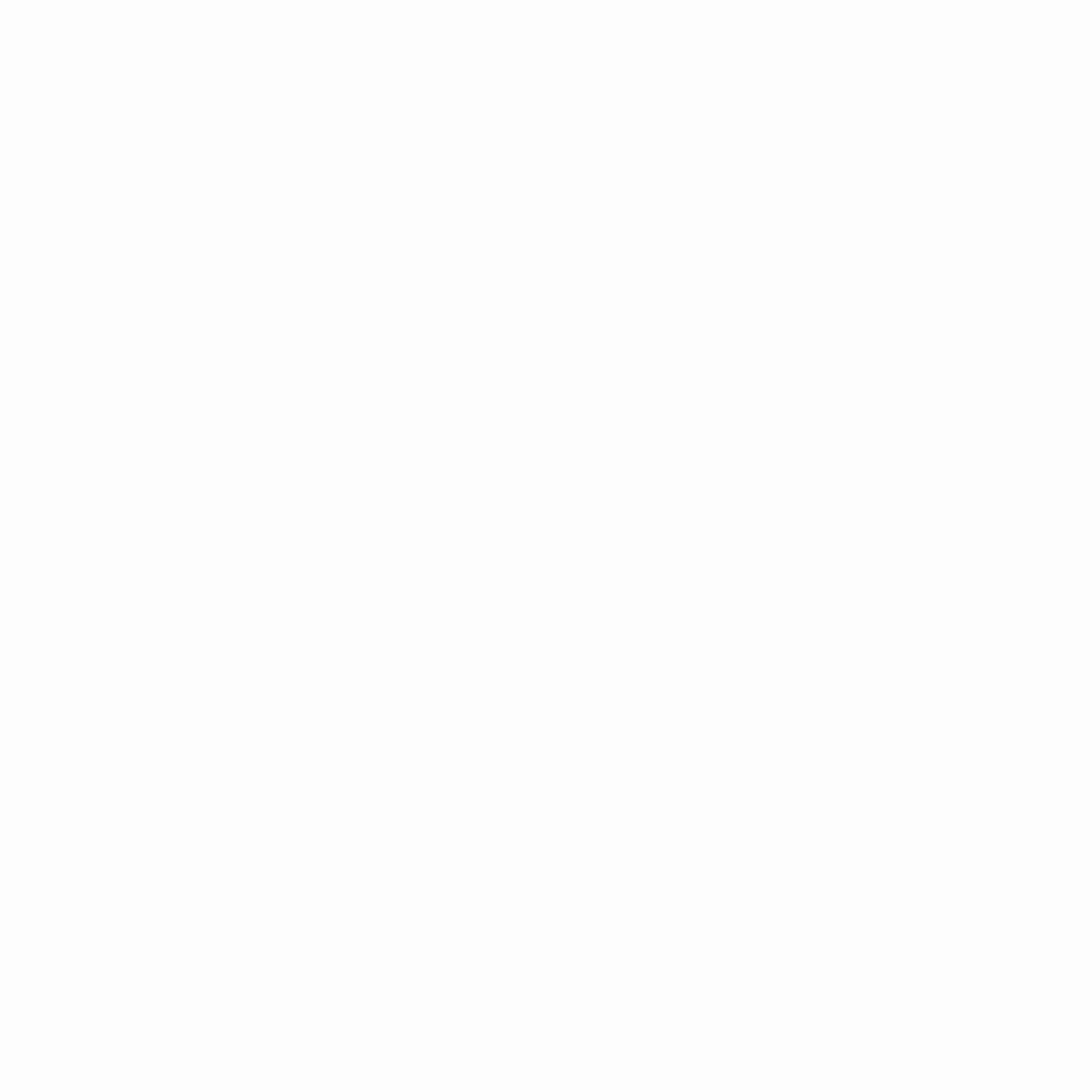
Publiacqua nella top 10 nazionale per la Qualità contrattuale
Tempi rapidi, accessibilità, chiarezza nella relazione con i cittadini: sono questi i principali parametri con cui in Italia si misura…
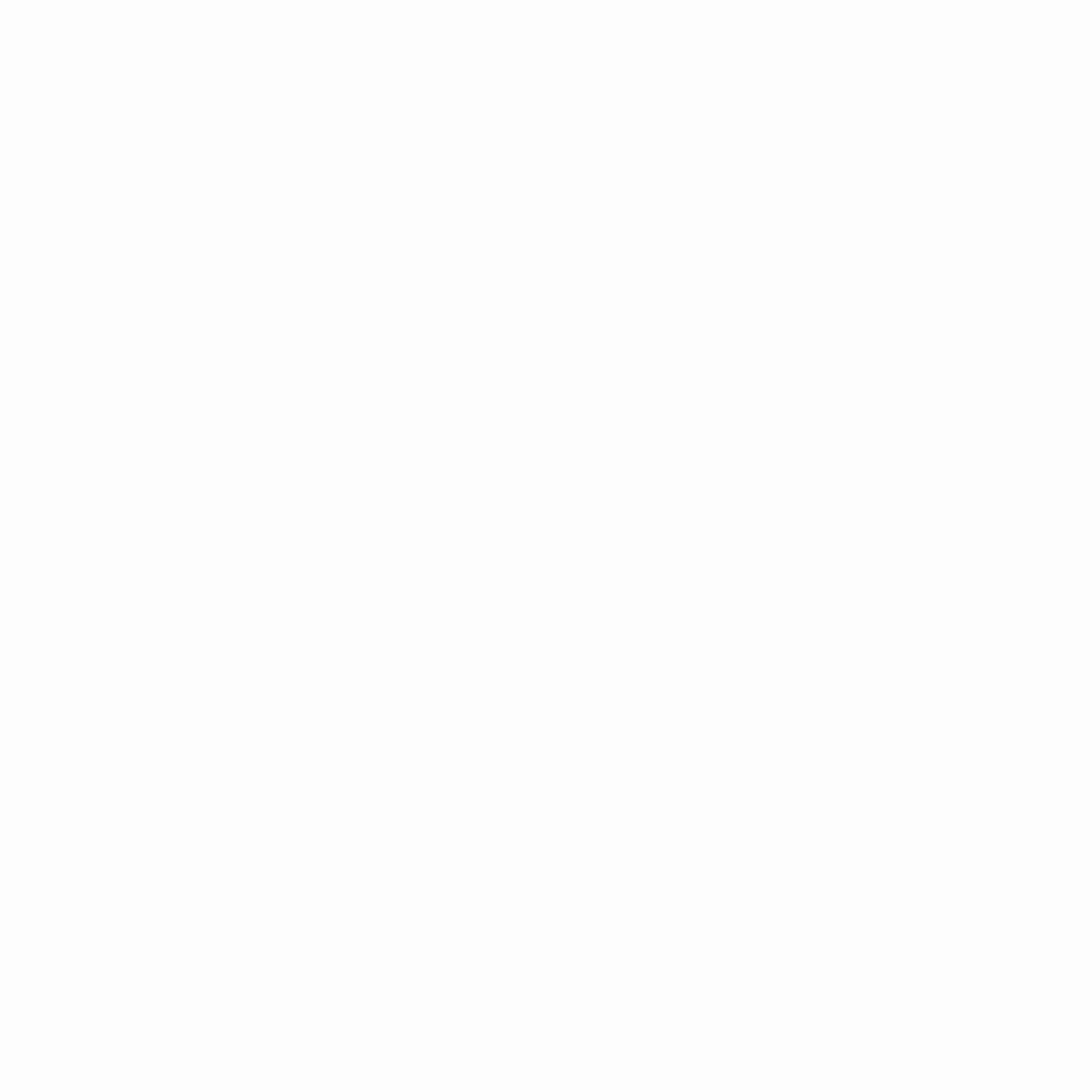
Chi determina la tariffa del servizio idrico integrato
Quando arriva la bolletta dell’acqua, può sorgere spontanea una domanda: chi determina veramente la tariffa del servizio idrico integrato? Non…
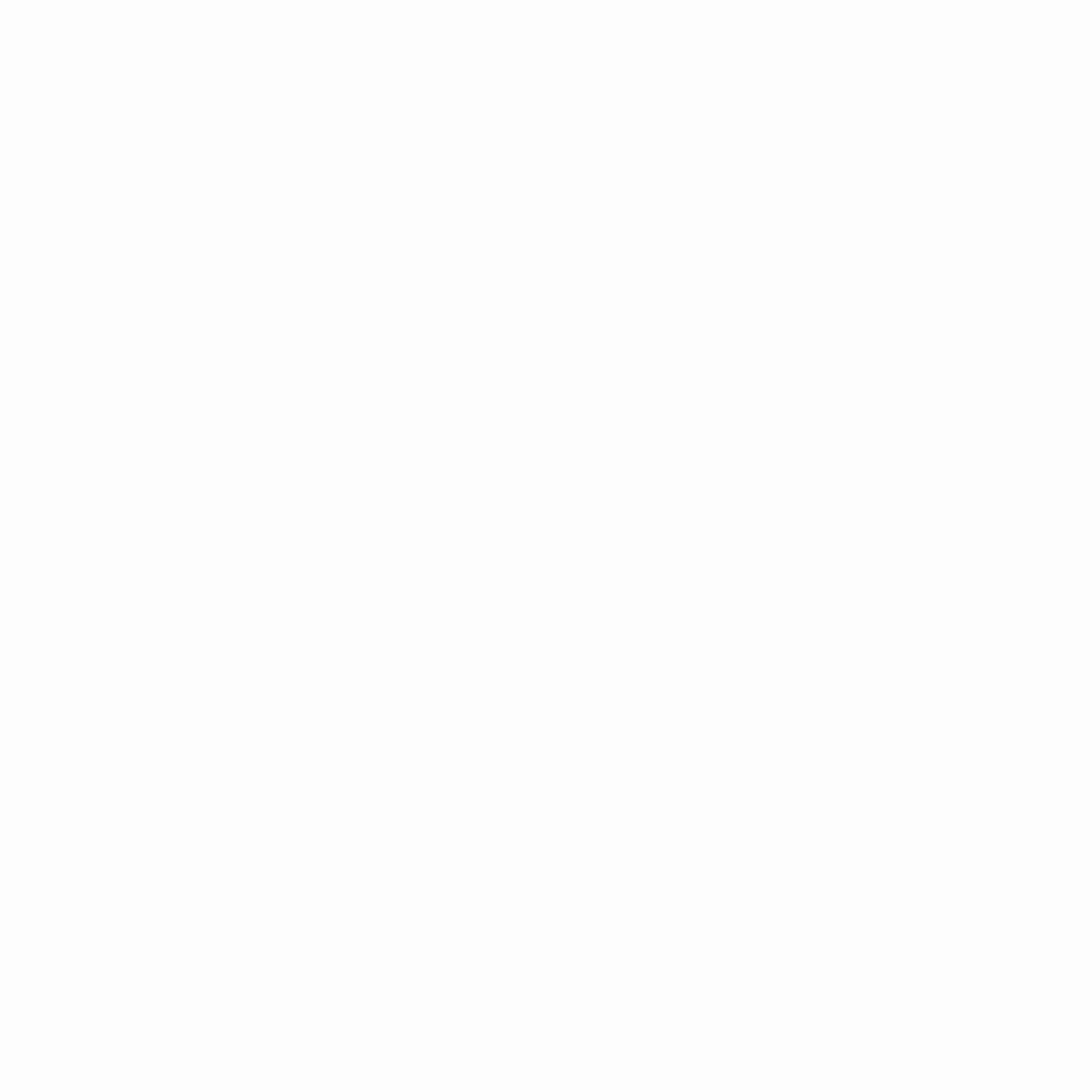
Perché la tariffa idrica non è uguale in tutta Italia
Paghiamo tutti l’acqua potabile, ma non allo stesso modo. A parità di consumi, famiglie che vivono in città diverse possono…
