Antichi acquedotti, serbatoi ottocenteschi, impianti più moderni ma comunque ricchi di fascino. Il volume Aquae ductae, dalla terra ai territori è un viaggio tra le immagini di Davide Virdis e le parole di Fabio Fabbrizzi, per scoprire sotto una luce diversa le infrastrutture idriche delle nostre zone: non semplici manufatti funzionali all’immagazzinamento e alla distribuzione, bensì “segni architettonici” che celano simboli e significati lontani. La gestione dell’acqua, infatti, è da sempre specchio della società e dei suoi mutamenti sociali, politici e tecnologici: nel corso della Storia questa fonte di vita è stata emblema del potere, protagonista di culti religiosi, motivo di guerre e sorgente di idee per soluzioni ingegneristiche innovative.
L’obiettivo del fotografo e architetto Davide Virdis è arrivato lì dove solo gli addetti ai lavori possono addentrarsi e ha realizzato un ritratto unico delle opere idriche presenti tra Firenze, Prato e Pistoia. Un racconto visuale che lungo le oltre 270 pagine del libro si dipana di pari passo al commento critico di Fabio Fabbrizzi, professore associato di Progettazione architettonica e urbana presso il DIDA-Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.
Se vuoi scoprire più da vicino queste affascinanti infrastrutture e il loro significato storico e architettonico, puoi scaricare la versione digitale del libro Aquae ductae, dalla terra ai territori compilando il form disponibile nella sezione “I Volumi della Qualità” sul sito di Publiacqua.
Com’è nata l’idea del libro “Aquae ductae”
La pubblicazione, realizzata su incarico di Publiacqua, è stata presentata dagli autori durante l’ultima giornata del Festival dell’Acqua 2024 che si è svolto a Firenze dal 24 e al 26 settembre. La campagna fotografica di Virdis ha toccato le principali infrastrutture del territorio, dall’acquedotto fiorentino dell’Unità d’Italia (l’ex Fabbrica dell’acqua, i serbatoi della Carraia e del Pellegino), alle costruzioni del Razionalismo (l’impianto di potabilizzazione di Santa Maria a Mantignano e quello di Prombialla nel pistoiese), fino ai complessi contemporanei come il depuratore di San Colombano, i potabilizzatori dell’Anconella e Pontassieve, l’invaso della Calvanella a Fiesole e il lago di Bilancino in Mugello, con la sua centrale idroelettrica.

Proprio per il valore evocativo che le immagini possiedono, in corso di realizzazione è nata l’idea di affiancare alle fotografie il commento di un esperto, il professor Fabio Fabbrizzi per poi racchiudere il tutto nel volume Aquae ductae. “L’intento era creare un rapporto paritetico tra parole e foto – spiega Virdis – le immagini non illustrano il commento scritto e viceversa i testi non sono una mera interpretazione degli scatti. Abbiamo invece pensato a due linguaggi paralleli che viaggiano insieme affrontando lo stesso argomento. Per quanto riguarda il mio lavoro ho scelto tre punti di vista diversi: la lettura degli elementi spaziali e architettonici; il loro rapporto con il paesaggio e il contesto circostante; l’analisi, quando possibile, della struttura all’opera”.
Infrastrutture idriche come simboli dell’evoluzione di una società
Anche sul fronte della parola, da questa narrazione sono emersi temi comuni, in base ai quali sono state delineate le diverse sezioni del volume: le nuove topografie, l’architettura “parlante” (prendendo in prestito il termine dallo storico dell’arte Emil Kaufmann); il paesaggio e la macchina; la razionalità del moderno; i nuovi paesaggi dell’utile; il dominio e l’emblematica della macchina. “La riflessione, in molti casi, ha fatto assurgere le infrastrutture a vere e proprie opere d’arte – dice il professor Fabbrizzi -. Da questi segni architettonici è emersa una storia fatta a volte di alleanze, a volte di dominio tra l’uomo e il mondo naturale, in momenti e contesti diversi. Oggi apriamo il rubinetto e diamo per scontato che da questo sgorghi acqua, ma non dobbiamo dimenticarci che non è stato sempre così. Al tempo dei Romani, ad esempio, portare acqua in una piazza era un’espressione di potere, mentre in tempi più recenti si è persa questa sorta di rappresentatività”.
Nel corso degli anni, con l’evoluzione della società del benessere, le infrastrutture hanno cambiato il loro valore simbolico, fa notare anche Virdis. “Prendiamo l’acquedotto ottocentesco fiorentino, una struttura ‘nobile’ dal punto di vista architettonico, poiché finalizzata alla custodia di una risorsa percepita come importantissima per la comunità. Basta vedere le fotografie del serbatoio della Carraia, che sembra una cripta di una chiesa. Se arriviamo invece alla seconda parte del Novecento l’elemento ‘estetico’ si affievolisce: i progettisti si sono concentrati nell’evidenziare le caratteristiche funzionali degli spazi, tenendo meno di conto l’aspetto estetico”. Un mondo “sommerso” sconosciuto alla stragrande maggioranza della popolazione, che grazie ad Aquae ductae viene riportato in superficie. Con una storia fatta di relazioni e legami viene così raccontata l’evoluzione sociale, politica e tecnologica di un intero territorio.
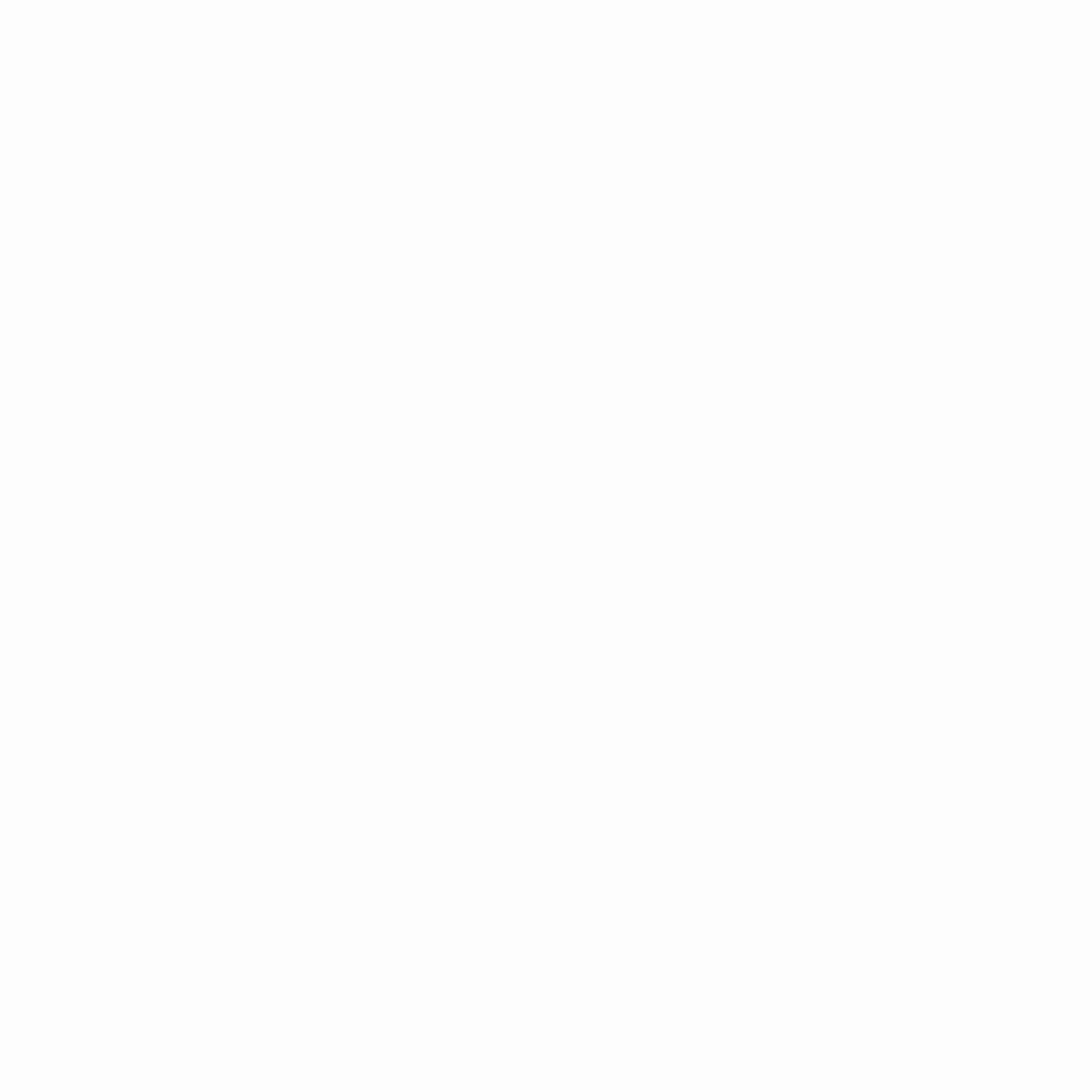
Potrebbero interessarti anche…
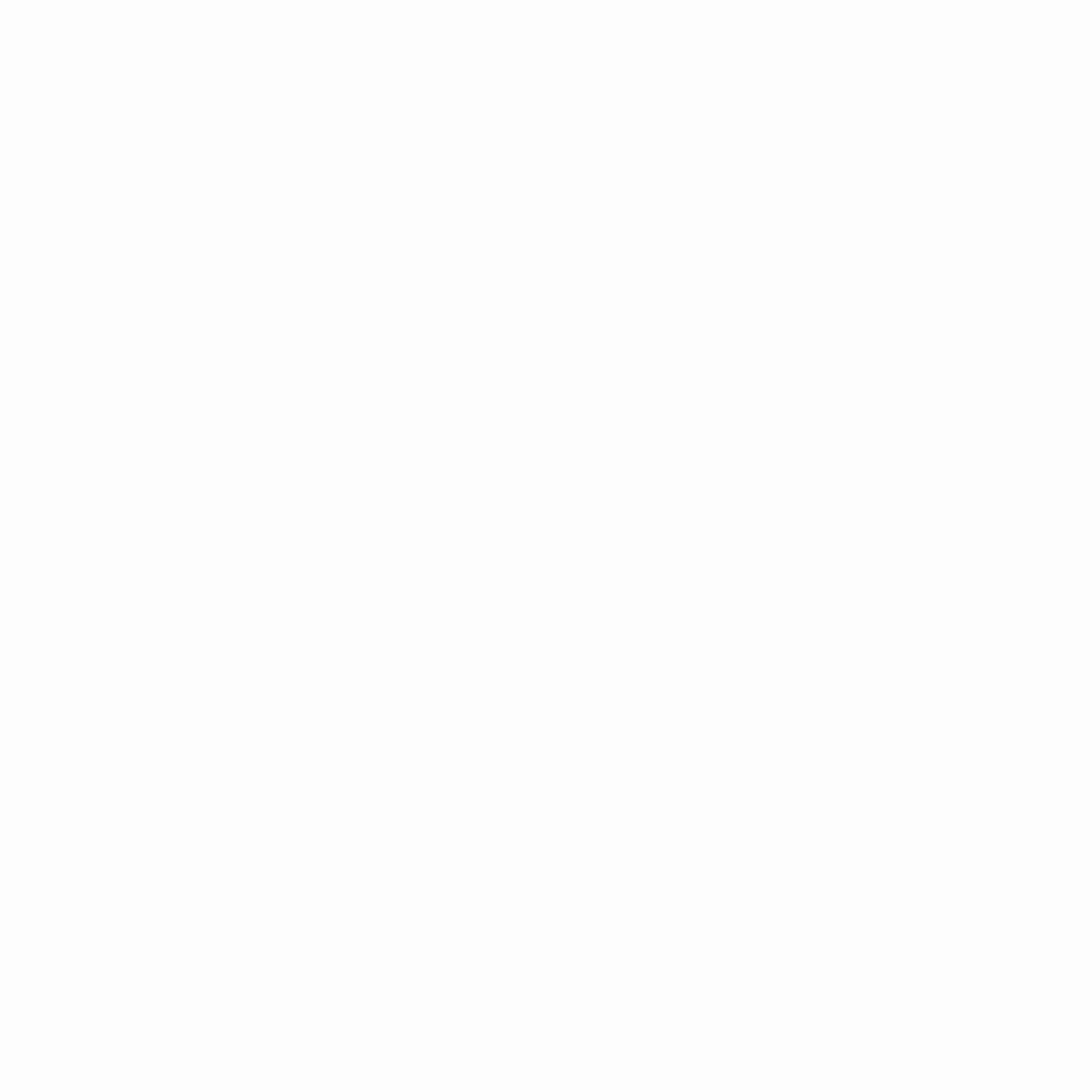
Publiacqua nella top 10 nazionale per la Qualità contrattuale
Tempi rapidi, accessibilità, chiarezza nella relazione con i cittadini: sono questi i principali parametri con cui in Italia si misura…
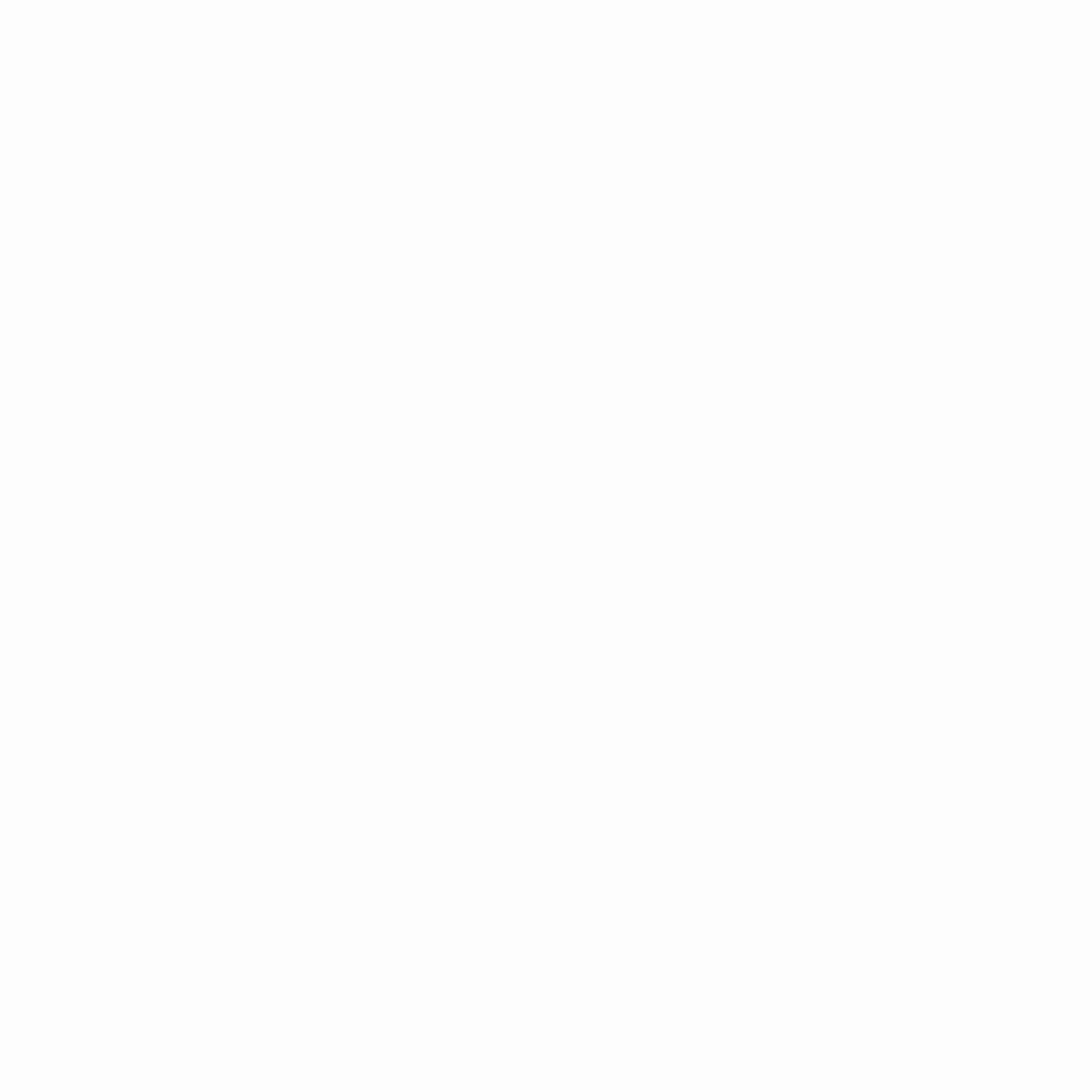
Chi determina la tariffa del servizio idrico integrato
Quando arriva la bolletta dell’acqua, può sorgere spontanea una domanda: chi determina veramente la tariffa del servizio idrico integrato? Non…
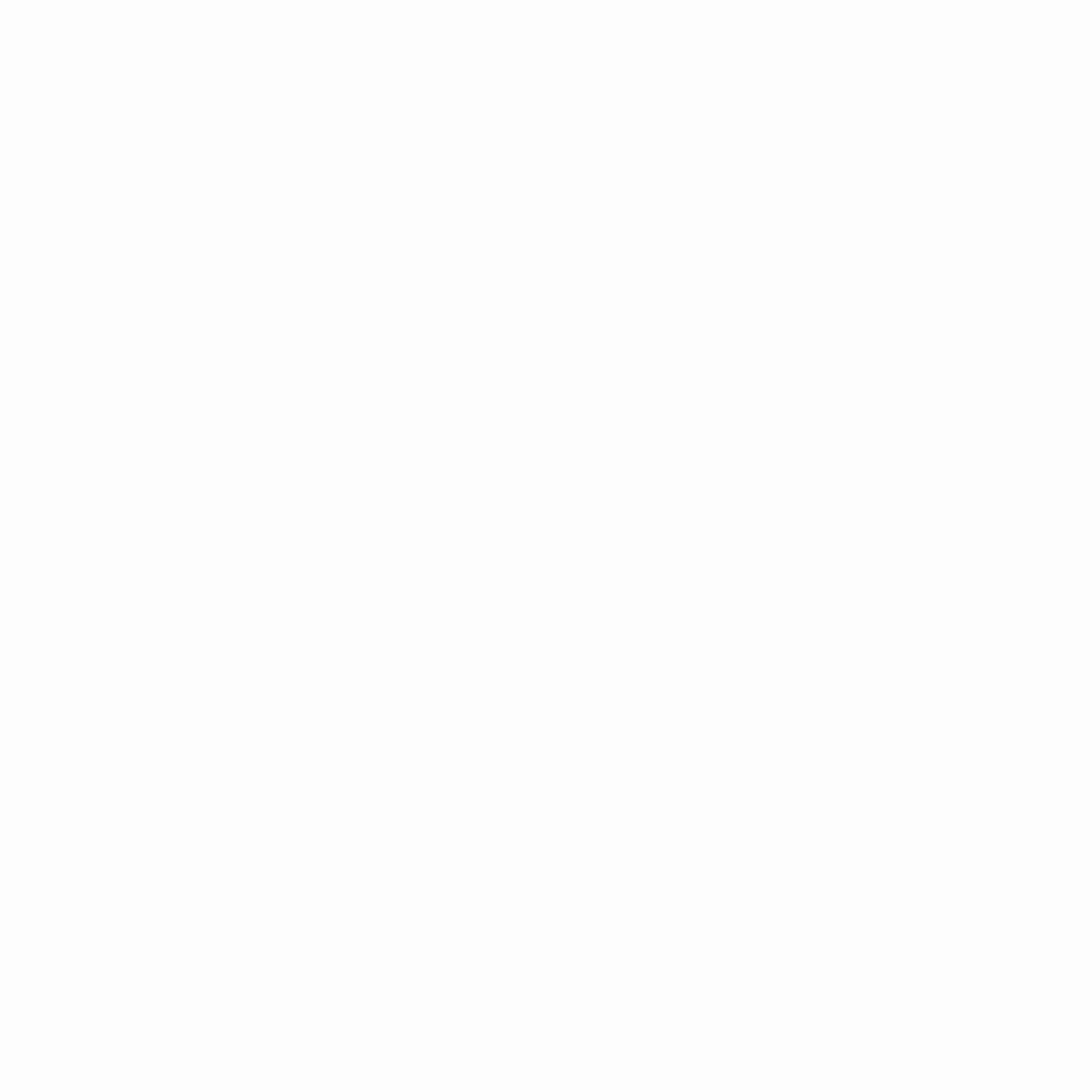
Perché la tariffa idrica non è uguale in tutta Italia
Paghiamo tutti l’acqua potabile, ma non allo stesso modo. A parità di consumi, famiglie che vivono in città diverse possono…
