Una risorsa sotto stress, a causa del cambiamento climatico che sta ridisegnando la geografia della disponibilità di acqua in Italia. Allo stesso tempo, in un decennio la tariffa idrica è aumentata del 40%, per sostenere gli investimenti infrastrutturali e per far fronte ai crescenti costi energetici. In questo quadro il settore idrico si conferma un comparto strategico, non solo per l’approvvigionamento potabile, ma anche per l’intera economia nazionale: il suo valore aggiunto nel 2023 ha toccato gli 11 miliardi di euro, avvicinandosi a quello generato da industrie chiave per il nostro Paese, come la farmaceutica. I dati arrivano dal Blue Book 2025, giunto alla quindicesima edizione, curato dalla Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia.
La filiera dell’acqua è infatti al centro di una fase di profonda trasformazione, spinta da nuove sfide ambientali e sociali, ad esempio la decrescita demografica. Gli ultimi dati fotografano un comparto sempre più rilevante, che al contempo deve affrontare profonde disuguaglianze territoriali.
L’aumento della tariffa idrica e la spesa pro-capite
Nel 2024 la spesa media per il servizio idrico integrato in Italia ha toccato i 384 euro per una famiglia tipo di tre persone, con un consumo annuo di 150 metri cubi. Un incremento del 5,4% rispetto al 2023, che conferma il trend in positivo delle tariffe: dal 2014 a oggi, la “bolletta” è salita in media del 40%, sebbene sussistano notevoli differenze a seconda del territorio di riferimento. La spesa più bassa si registra nelle regioni del Nord (337 euro l’anno), la più alta al Centro (466 euro), mentre il Sud (381 euro) si piazza leggermente sotto la media nazionale pur presentando forti disomogeneità al suo interno. Differenze che riflettono le specifiche esigenze infrastrutturali delle singole zone.

A pesare sugli aumenti, negli ultimi anni, è stato in particolare il vertiginoso rialzo del costo dell’energia elettrica che ha un’incidenza importante sulle spese operative del servizio. Tuttavia, alla base delle variazioni delle tariffe c’è anche la capacità di investimento da parte dei gestori. Il Blue Book 2025 evidenzia come il settore idrico italiano stia vivendo un momento di metamorfosi, caratterizzato da un deciso incremento degli investimenti, dal graduale ammodernamento delle infrastrutture e da un miglioramento della governance.
Sul fronte degli investimenti, secondo l’analisi studio della Fondazione Utilitatis, si è passati dai 63 euro per abitante del 2021 agli 80 euro pro-capite nel 2025 (+27%), per un totale di circa 8 miliardi di euro. La maggior parte delle risorse, quasi un terzo, è stata destinata alla riduzione delle perdite, il 14% è stato speso per l’adeguamento del sistema fognario e un altro 14% per la depurazione delle acque reflue.
Diminuisce la disponibilità di acqua
In questo contesto, i cambiamenti climatici hanno reso ancora più complessa la sfida per garantire l’approvvigionamento e la sicurezza della risorsa. A influenzare in modo negativo la disponibilità di acqua in Italia sono l’impennata delle temperature superficiali medie, che dal 1991 al 2024 hanno fatto registrare nel nostro Paese un +1,6 °C, il conseguente intensificarsi del fenomeno di evapotraspirazione e l’estrema variabilità delle piogge, con un’alternanza più marcata tra periodi di siccità e precipitazioni violente.
Negli ultimi 20 anni, nel Centro Italia la frequenza di fasi con deficit idrici è cresciuta del 35%, quella con surplus del 23%. Il Drought Central, l’osservatorio sulla siccità curato dall’Istituto per la Bioeconomia del CNR, indica un mutamento di paradigma: se fino agli anni 2000 gli eventi siccitosi prolungati colpivano principalmente i bacini del Centro-Sud (Tevere, Garigliano, Volturno, Ofanto Basento, Tirso e Simeto), dal 2000 in poi è stato il Centro-Nord a essere interessato da un aumento dell’intensità e della reiterazione delle siccità, in particolare per i bacini dell’Arno e del Po, culminato, per quest’ultimo, con l’emergenza 2021-2022.
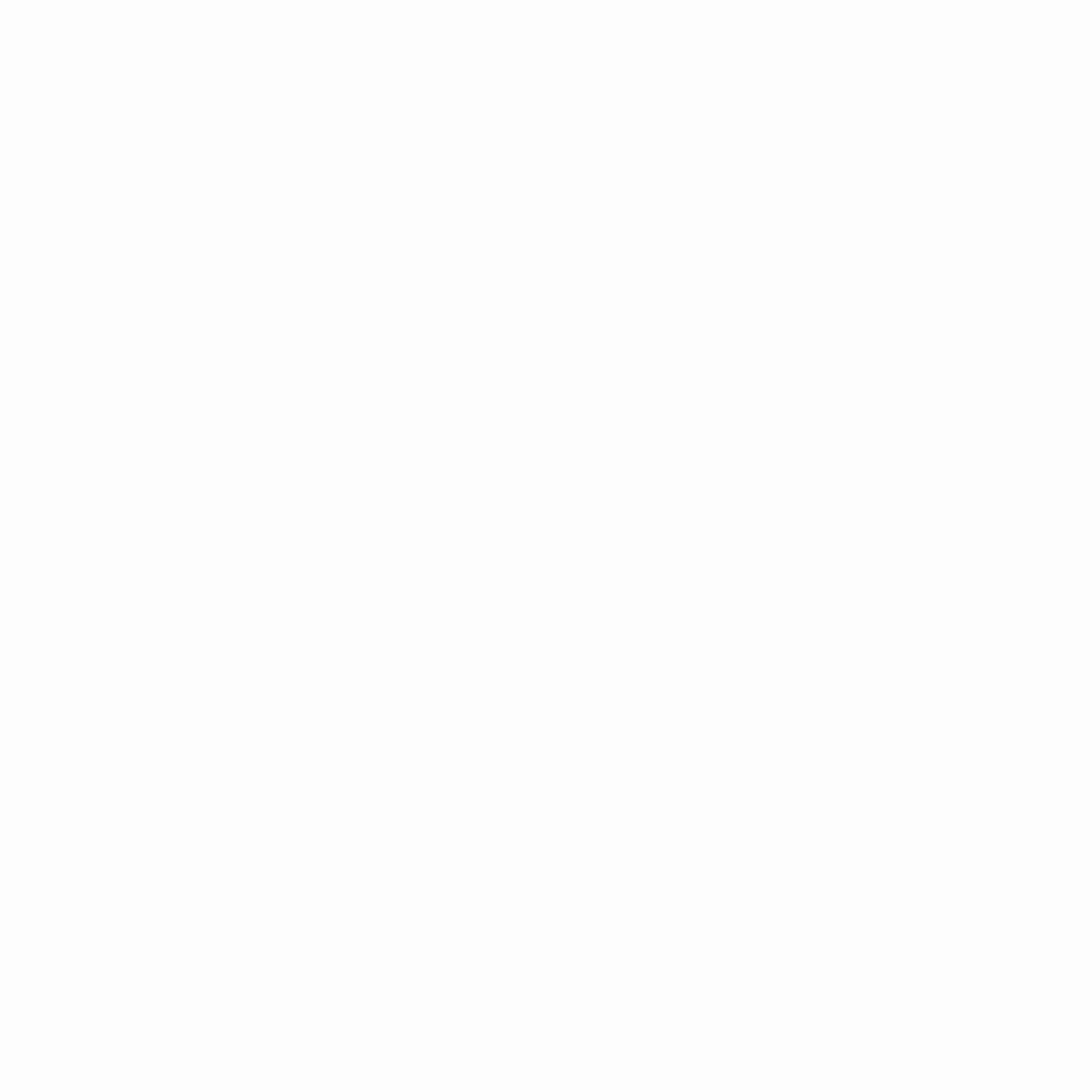
Le ricadute economiche e occupazionali del comparto acqua: i dati del Blue Book 2025
L’acqua si conferma quindi un bene essenziale e una leva strategica per lo sviluppo sostenibile: la gestione idrica integrata riveste infatti un ruolo di primo piano nell’economia italiana. Nel 2023 le aziende del settore hanno registrato un fatturato complessivo di 8,9 miliardi di euro (pari allo 0,4% del PIL nazionale), dando lavoro a oltre 29.000 persone, ovvero lo 0,11% del totale degli occupati del Paese e lo 0,5% di quelli dell’industria.
Ma l’impatto del comparto va ben oltre. Solo nel 2023, la filiera estesa dell’acqua ha generato un valore aggiunto diretto di 11 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,5% tra il 2015 e il 2023. Un ritmo superiore a quello dell’intero segmento manifatturiero (+4,1%) e alla crescita media nazionale (+3,2%).
Inoltre, se si prende in considerazione l’indotto, il valore aggiunto del ciclo idrico esteso raggiunge i 30,6 miliardi di euro, con 257 mila posti di lavoro generati. Allargando lo sguardo agli ambiti produttivi che utilizzano l’acqua come risorsa essenziale – dall’agricoltura al manifatturiero – si arriva a un valore aggiunto di 383 miliardi di euro, pari a un quinto del PIL. Il Blue Book 2025 stima, dunque, che per ogni euro di valore aggiunto generato dalla filiera estesa dell’acqua si attivino altri 1,8 euro, pari a un moltiplicatore economico del 2,8.
Il Blue Book 2025 è consultabile sul sito della Fondazione Utilitatis.
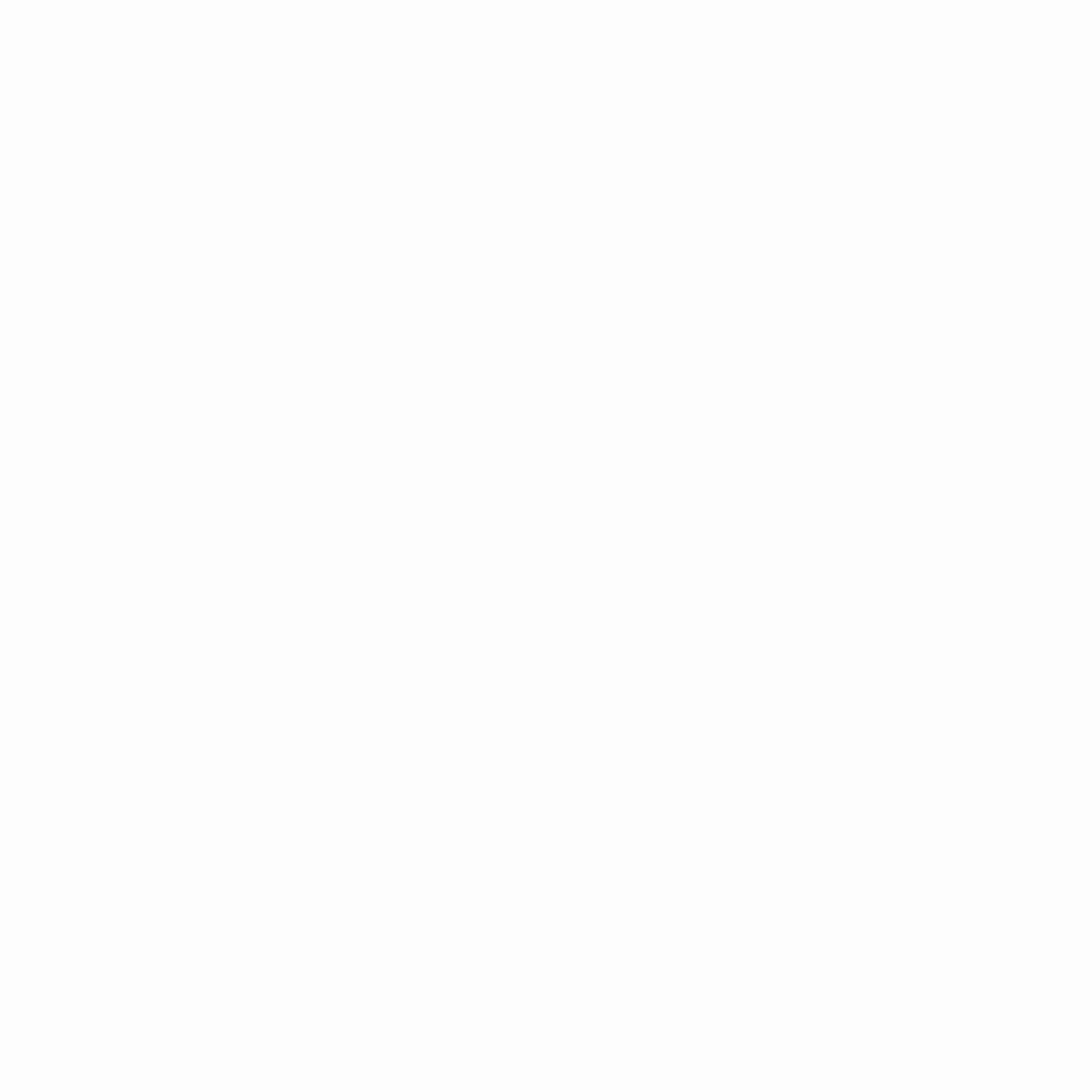
Potrebbero interessarti anche…
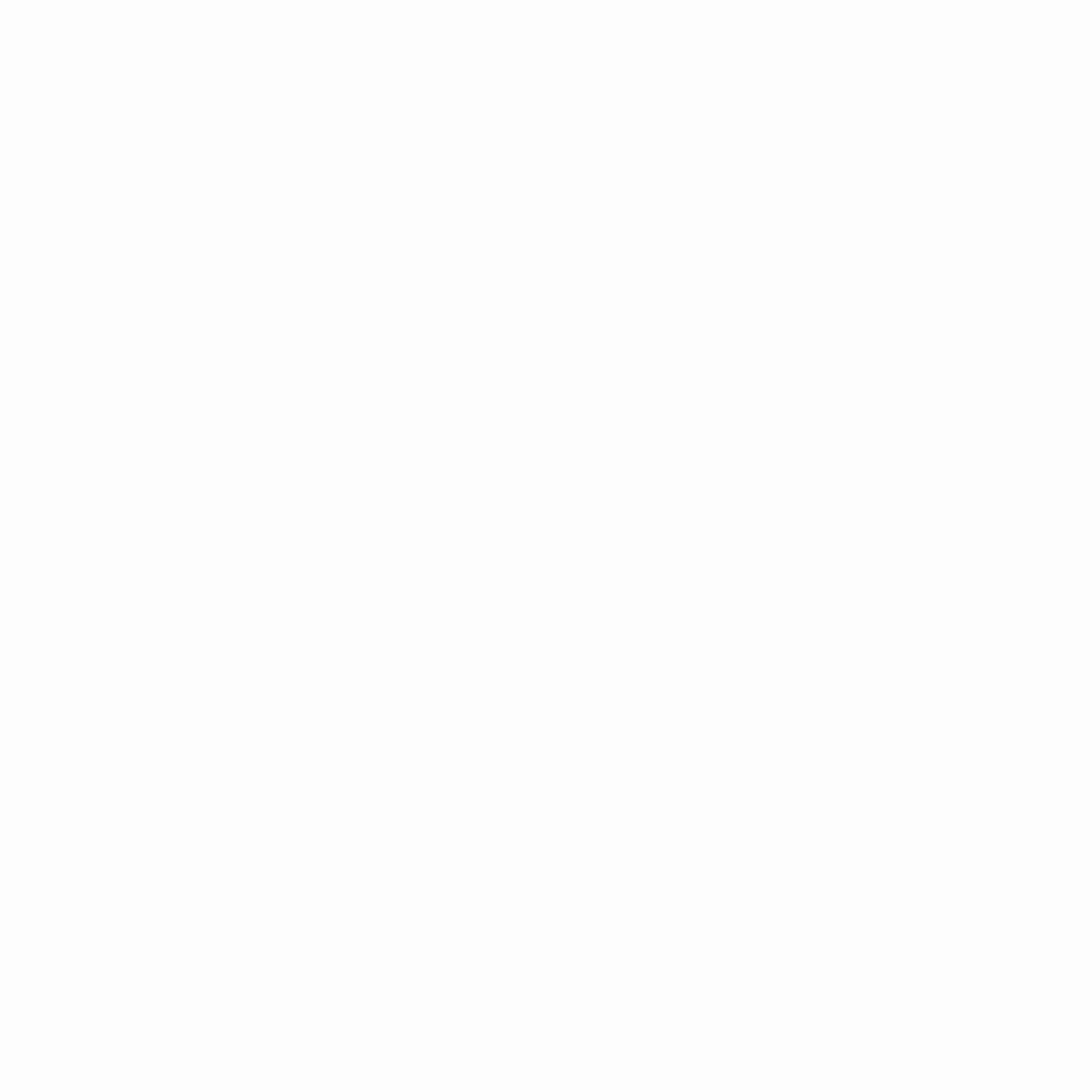
Publiacqua nella top 10 nazionale per la Qualità contrattuale
Tempi rapidi, accessibilità, chiarezza nella relazione con i cittadini: sono questi i principali parametri con cui in Italia si misura…
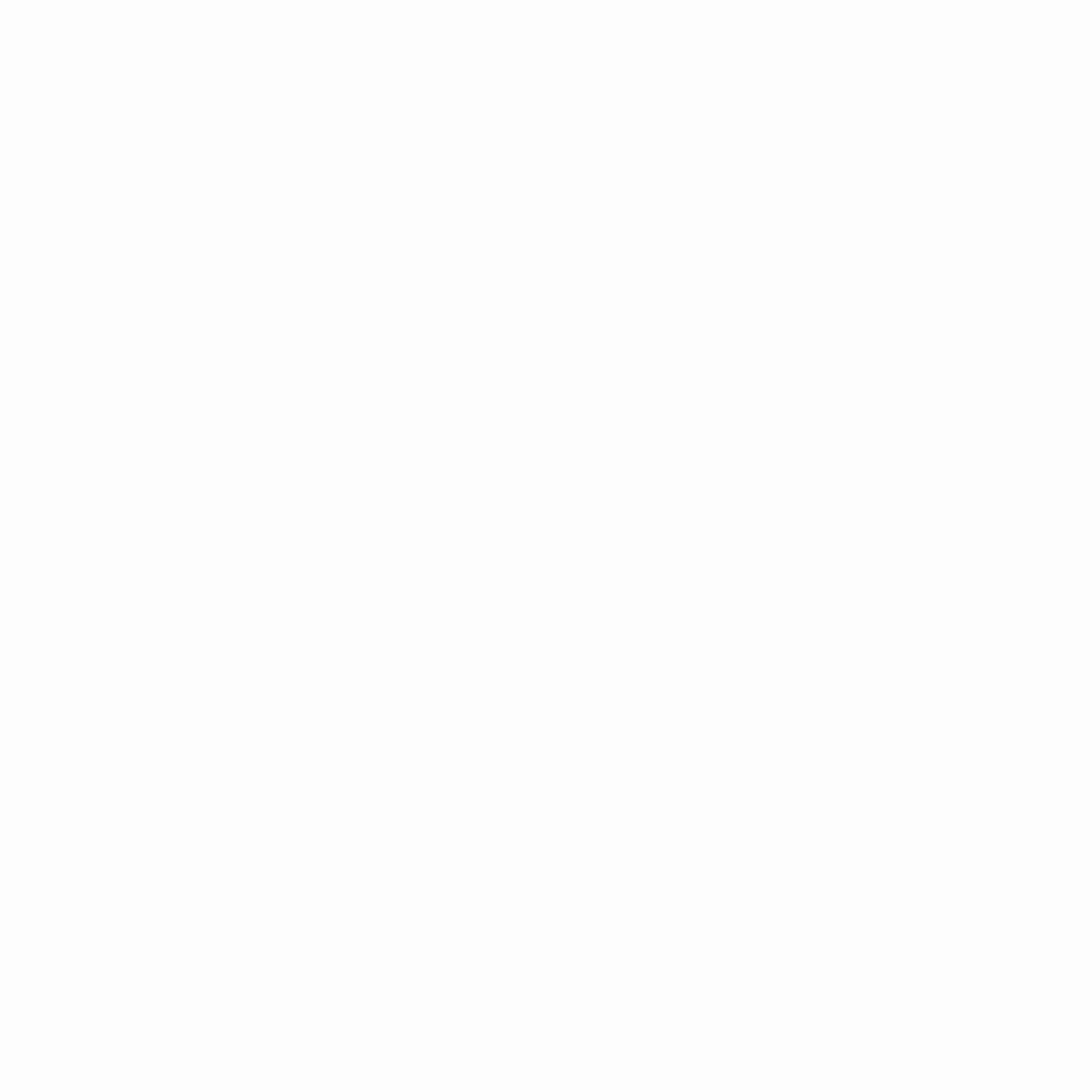
Chi determina la tariffa del servizio idrico integrato
Quando arriva la bolletta dell’acqua, può sorgere spontanea una domanda: chi determina veramente la tariffa del servizio idrico integrato? Non…
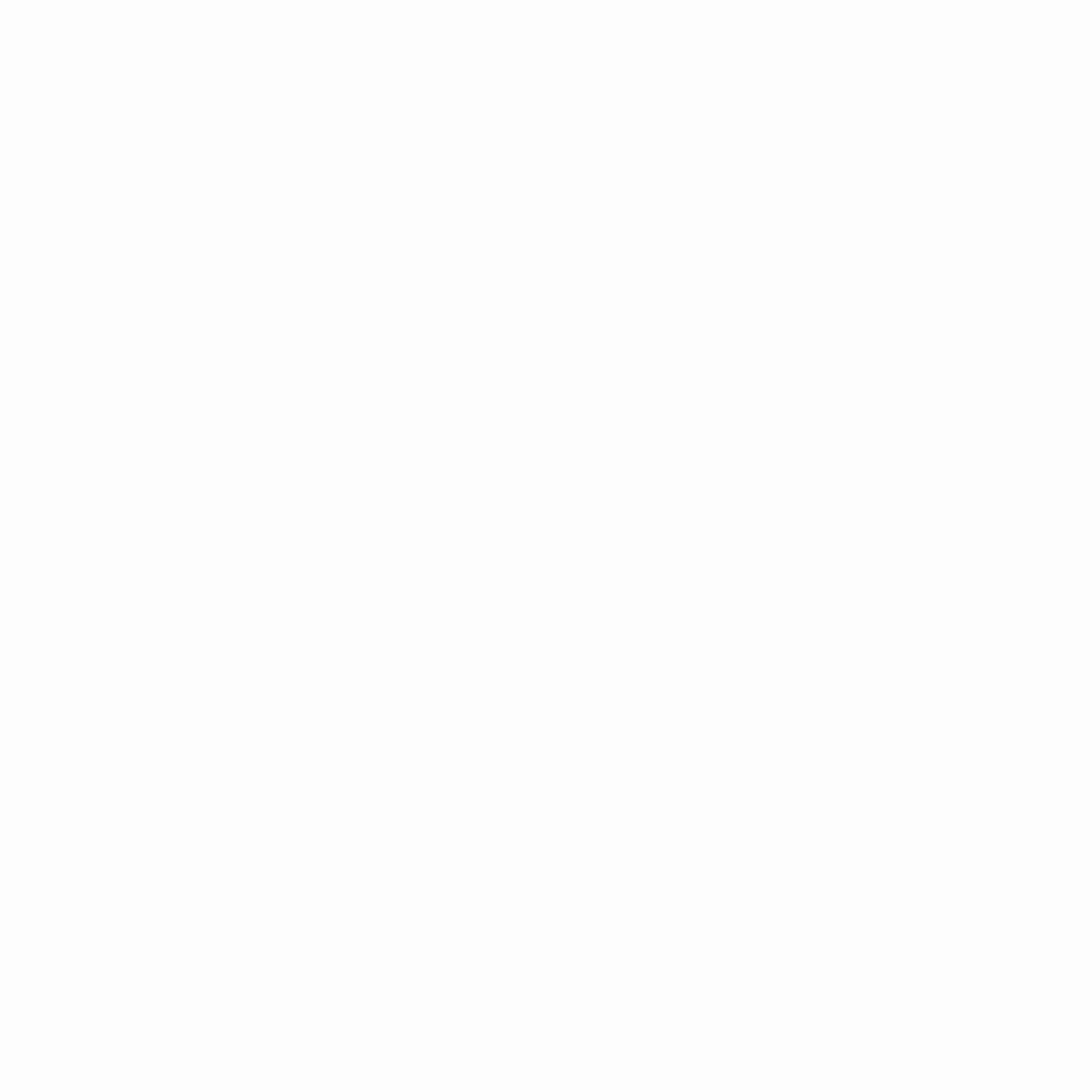
Perché la tariffa idrica non è uguale in tutta Italia
Paghiamo tutti l’acqua potabile, ma non allo stesso modo. A parità di consumi, famiglie che vivono in città diverse possono…
